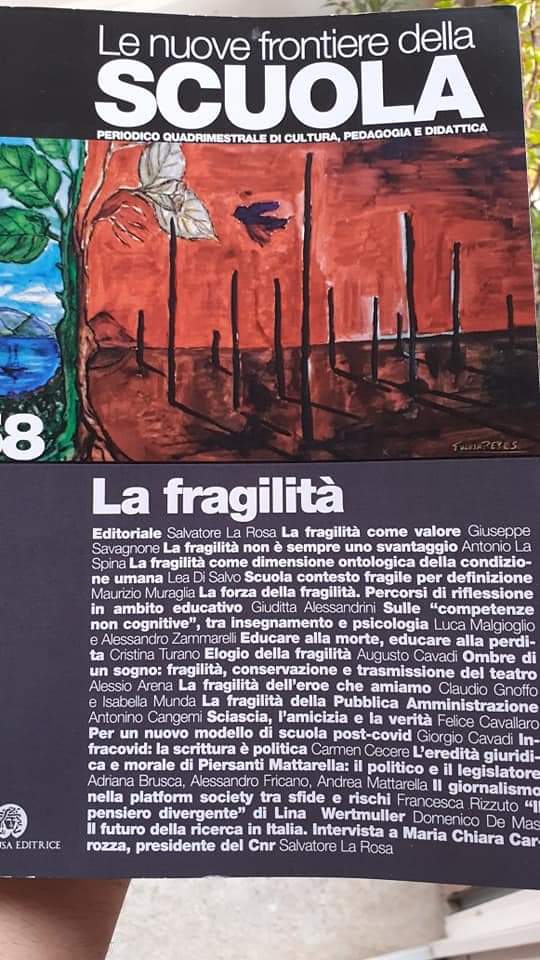
È stato pubblicato sulla rivista “Le Nuove Frontiere della Scuola” (numero 58, “La fragilità”) un articolo sulle competenze non cognitive scritto a quattro mani da uno psicoanalista, Alessandro Zammarelli*, e da un insegnante, Luca Malgioglio. Ne riportiamo qui un breve passaggio, che mostra anche dal punto di vista dello specialista l’intima contraddittorietà della definizione “competenze non cognitive” e la confusione concettuale che essa introduce nel dibattito pubblico.
***
[Questa è] la definizione che l’onorevole Maurizio Lupi, presidente dell’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, ha dato delle “competenze non cognitive”, nel discorso in cui motiva la proposta della loro adozione nell’ambito della legislazione scolastica del nostro Paese:
“Con character skills, soft skills o non cognitive skills si intendono tutti quei modi di definire un apprendimento in ambito scolastico e lavorativo che non sia limitato solo al coinvolge le capacità cognitive (ricordare, parlare, comprendere, stabilire nessi, dedurre, valutare) ma che implichi anche lo sviluppo di tutte quelle predisposizioni della personalità (l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la sicurezza personale, la capacità di prendere iniziative, di pensare per problemi, la capacità di auto-regolarsi, l’affidabilità, l’adattabilità, ecc.) che sono sempre più rilevanti nella società moderna”.
Quando si parla di “adattabilità” e “affidabilità” sembra davvero che ci si muova al confine tra il terreno della crescita e della formazione della persona e quello dell’azienda e della produttività lavorativa; e quando Lupi parla delle competenze del “pensare per problemi” o del “prendere iniziative”, ci si può legittimamente chiedere su quale base si possano risolvere problemi o prendere iniziative se non si ha la conoscenza – cognitiva, immaginiamo – di tali problemi e del contenuto di tali iniziative. Un’operatività non sostanziata da processi di pensiero, insomma, sembra una contraddizione in termini, a meno che non si esca dall’ambito dell’educazione e non si entri in quello dell’addestramento; ma questo passaggio, come è ovvio, non riguarda e non può riguardare la scuola.
Forse, quando parla di “competenze non cognitive”, qualcuno intende fare riferimento, oltre a quelle operative, anche alle dimensioni affettive, relazionali ed etiche dell’essere umano. Ma – tenendo conto delle riflessioni svolte nella prima parte del presente articolo – pensiamo davvero che sia possibile separare tali dimensioni da quella cognitiva? Come si proponeva sopra, il termine “competenza” potrebbe essere utilizzato per sintetizzare tutta una serie di processi cognitivi, di processi di pensiero, in cui intervengono sistemi complessi dell’essere umano come la memoria, le emozioni e la storia personale. Per fare un esempio attinto dalla pratica psicoanalitica, affermare che una persona ha una buona capacità di capire, pensare ed elaborare le proprie emozioni, equivale a dire che questi ha una certa competenza nel leggere e integrare i propri stati emotivi. Difficilmente si potrebbe dire la stessa cosa di una persona che non è in grado neanche di dare un nome alle proprie emozioni o addirittura di percepirle, di dire o pensare ciò che prova. Non si può avere una competenza sulle emozioni se prima non le si conosce, o se non si eliminano le barriere che non permettono questo processo di conoscenza. Come ci ha insegnato Bion (1970-1973), le emozioni esistono sempre, anche quando si manifestino soltanto tramite equivalenti fisiologici (elementi Beta), senza raggiungere una adeguata capacità di essere pensate e dichiarate; oppure possono essere presenti in seno a una funzione Alfa acquisita, matura, che ci permetta di pensarle, esprimerle ed elaborarle.
Ecco, le “competenze non cognitive” producono in quest’ottica un grande paradosso. Come posso pensare alle competenze senza pensare? Come posso sapere di essere competente se non so cosa ho appreso, come posso sentirmi competente senza aver attraversato tutta quella serie di processi cognitivi che hanno fatto della mia esperienza reale, integrata con le emozioni, un’esperienza di crescita, di apprendimento e di relazione? Questi processi interni si proiettano poi in attività esterne, che richiedono regole e strumenti pratici; i processi cognitivi e di apprendimento possano concretizzarsi in quelle che, solo in futuro, si chiameranno competenze; ed è solo a questo punto che il sistema pedagogico interviene come facilitatore dell’integrazione e dell’applicazione pratica di tutti questi sistemi interni.
*Alessandro Zammarelli è Psicologo ad indirizzo Clinico, Psicoterapeuta e Psicoanalista, specializzato in Psicoterapia Individuale e in lettura Psicodinamica dei Gruppi. È Socio e Psicoanalista della Sipre (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) e membro del consiglio di Centro della Sipre di Roma. È fondatore insieme al coautore dell’articolo del movimento La nostra scuola ed è membro del consiglio direttivo dell’associazione La nostra scuola – Agorà 33. Ha lavorato a lungo presso gli sportelli di ascolto psicologici nella scuola.
***
Qui di seguito la versione integrale dell’articolo
Sulle “competenze non cognitive”, tra insegnamento e psicologia
Nell’analisi della definizione “competenze non cognitive”, nel suo concreto contenuto di realtà, sarebbe importante tentare un approccio interdisciplinare che tenga insieme pedagogia, psicologia ed effettiva esperienza di insegnamento. Il contributo che qui si vuole portare da parte dei due autori, un insegnante e uno psicoanalista, è proprio quello volto a sviluppare un discorso integrato tra gli ambiti della psicologia e della didattica, che possa a sua volta aprire un confronto fecondo con la riflessione pedagogica.
A questo proposito vorremmo porre una questione preliminare, quella del rapporto tra discipline pedagogiche e discipline psicologiche. La nostra idea di queste due discipline accoglie il concetto di “integrazione”. Non può esistere una pedagogia che non attivi esperienze psicologiche, come non può esistere alcun approccio di intervento psicologico che non tenga conto di un setting, di un insieme di regole, con il loro valore educativo, di un apprendimento, di una pedagogia. Avere una visione disaggregata delle due discipline limita il potere esplicativo e di intervento effettivo che esse possono fornire in alleanza. A ben vedere, questi sistemi – diciamo appunto psicologia, pedagogia e insegnamento – sono a loro volta fondati sui sistemi delle “emozioni” e dei “processi cognitivi”. Il sistema emozionale interviene, in un processo sano, in qualunque esperienza di insegnamento e apprendimento, e le dà il suo ‘colore’, la sua caratteristica singolare percepita nei termini del sentire psichico. A loro volta i processi cognitivi, i processi di pensiero, la percezione, la simbolizzazione, la categorizzazione, permettono alle emozioni di incanalarsi armoniosamente nelle attività di apprendimento e insegnamento. Se le emozioni e i processi cognitivi si sviluppano in maniera integrata, le emozioni possono essere pensate. Non a caso, l’incapacità di pensare le emozioni, in termini psicologici, rappresenta uno dei sintomi che appartiene alle configurazioni di personalità più problematiche e più gravi in ambito clinico (Krystal, 1968).
Il sistema delle emozioni non è solo importante per l’evoluzione e lo sviluppo dell’essere umano, per una percezione sé come persone integrata e coerente: interviene anche nel facilitare o nel contrastare l’apprendimento e l’insegnamento, poiché interferisce in maniera significativa sui sistemi della memoria (Pally, 2003; Siegel, 1999). Quando, anche in un contesto terapeutico, si vuole spiegare in maniera semplice la funzione delle emozioni, le si può paragonare a un evidenziatore che sottolinei, come appunto un pennarello su carta, l’esperienza intrapsichica e interpersonale dell’essere umano. L’emozione ha una funzione importante nel consolidare il ricordo di ciò che si è vissuto o appreso, ma può anche determinare una discontinuità dei sistemi della coscienza (Liotti, 1993), intervenendo sulla memoria nel momento in cui tale emozione, che sottolinea un’esperienza vissuta, ha una valenza negativa o intollerabile. Possiamo dire che il sistema emozionale è sempre presente nell’essere umano: a partire dal livello biologico, può essere poi collocato in un processo di pensiero (processo cognitivo) che codifica, integra, simbolizza e incanala l’emozione. Se le emozioni sono lontane dalla capacità di attivare una possibilità di pensiero, una capacità cognitiva, questo significa che qualcosa non sta funzionando, nella persona o nella relazione. Alla luce di ciò, risulta difficile pensare di dislocare separatamente pedagogia e psicologia, le emozioni e i processi cognitivi dell’insegnamento e dell’apprendimento. In questi processi intervengono infatti, per sintetizzare:
1- La memoria. Il sistema mnestico è fondamentale: per insegnare il docente rievoca contenuti che ha appreso e li integra con i propri sistemi emozionali; codificati poi attraverso processi cognitivi, vengono a seconda dei casi spiegati, condivisi, rielaborati insieme alla classe degli studenti. Il sistema della memoria è fondamentale anche per l’apprendimento e per la formazione di quelle che chiamiamo competenze. In termini psicologici e nell’ambito di questo discorso, la competenza potrebbe essere considerata la conseguenza di un processo cognitivo che riguarda lo studio e la rievocazione mnestica dei contenuti associati ai personali sistemi emozionali dello studente, in sede di verifica e di lavoro futuro. Possiamo ipotizzare quindi che nel termine “competenze” sia indicato un insieme di processi cognitivi messi in moto dal passaggio e dalla rielaborazione di contenuti culturali nella relazione tra insegnante e studente. Non può essere concepito come un punto di partenza, ma solo come un punto di arrivo, risultato di tutto un corteo di attività cognitive.
2- Le emozioni. Come abbiamo anticipato poco sopra, le emozioni integrate ai processi di pensiero sottolineano e ‘colorano’ le esperienze, comprese quelle scolastiche dell’insegnamento e dell’apprendimento; possono renderle più efficaci, anche assegnando loro una priorità all’interno del sistema mentale. In termini evolutivi, possiamo dire che se un’esperienza è corroborata da un’emozione rilevante, essa avrà maggiori possibilità di essere richiamata alla memoria. Se un’esperienza emozionalmente traumatica può determinare una discontinuità della coscienza, interferendo con i sistemi della memoria (dissociazione, nei casi più gravi), un’esperienza emozionale rilevante può facilitare l’apprendimento e la rievocazione di contenuti importanti per la vita della persona. Questo ci fa intravedere come la possibilità di condividere contenuti culturali incanalando emozioni positivamente riconosciute o comunque rilevanti, grazie ai processi cognitivi, favorisca un insegnamento più efficace e un apprendimento migliore da parte dello studente. Tutto questo può avvenire, chiaramente, solo se esiste una relazione tra insegnante e studenti.
Torniamo ora alla questione fondamentale che vogliamo porci: ha davvero senso parlare di “competenze non cognitive”? Diciamo subito che non possiamo affrontare esaurientemente il dibattito generale sulle “competenze”, concetto la cui definizione appare ancora molto incerta e risente del posizionamento ideale – o ideologico – dei diversi autori che se ne occupano e delle indicazioni operative (ad esempio quelle contenute nei diversi documenti sull’educazione dell’Unione Europea) che dall’idea di “competenze” si vogliono trarre; questione, come si vede, più politica che scientifica. Poco sopra abbiamo abbozzato una definizione che può valere come ipotesi di lavoro, quella per cui la “competenza” è il risultato finale di una serie di processi. Per dare solo un’idea dell’ampiezza del conflitto delle interpretazioni che ruotano attorno al concetto di competenza, troppo spesso presentato come auto-evidente, ci limitiamo a rimandare alle interessanti riflessioni di Mauro Boarelli, che vede nell’adozione didattica del concetto di competenza un progressivo slittamento delle teorie attivistiche sull’educazione verso il linguaggio dell’azienda e della competizione. Boarelli, soprattutto, individua una serie di generalizzazioni che permettono un’applicazione e una sovrapposizione del concetto di competenza alle realtà più disparate, con effetto di auto-validazione che chiude la porta a qualunque ulteriore riflessione. Questo è un esempio delle sue argomentazioni:
“Il discorso sulle competenze si sviluppa intorno a quattro elementi principali. Il primo è la retorica della complessità: per fare fronte ad essa ciascun individuo deve imparare a risolvere problemi (‘problem solving’) in situazioni specifiche, inedite, sempre mutevoli. Questa rappresentazione è, da un lato, irrealistica, perché la vita quotidiana è strutturata non solo sui continui e inarrestabili cambiamenti, ma anche sulla sedimentazione dell’esperienza. Dall’altro lato è parziale, poiché le situazioni che gli individui devono affrontare nel corso della vita non sono tutte della stessa natura: molte di esse non prevedono un approccio immediatamente risolutivo ma, al contrario, obbligano ‘a un tempo di esplorazione, di riflessione, di esitazione, così come a dei tentativi falliti’. La seconda componente del discorso è la sua dimensione totalizzante. Le definizioni volutamente vaghe ed estremamente ampie adottate per descrivere il concetto comprendono potenzialmente ogni aspetto della vita umana. Ciascuna azione può diventare competenza e – di conseguenza – essere sottoposta a processi formali di apprendimento e misurazione.
[…] La generalizzazione, in sostanza, rende omogeneo ciò che invece dovrebbe essere differenziato. Inoltre, continua Goody [l’antropologo Jack Goody] nessuna competenza può esistere al di fuori di un contesto specifico. Come si può sostenere – ad esempio – che la flessibilità rappresenti sempre e comunque una facoltà positiva di cui ciascuno deve essere provvisto per far fronte ai problemi posti dalla complessità senza considerare il valore dei suoi opposti?”. La costanza, la perseveranza, la capacità di non arrendersi non sono forse competenze altrettanto importanti e necessarie nella vita pubblica?”.
Le posizioni sull’argomento, come si diceva, sono molto diversificate: è impossibile darne conto qui, anche se sarà indispensabile interrogarci almeno sul rapporto che c’è tra conoscenze e competenze, questione che pure fa parte di questo ampio dibattito. Fortemente critico nei confronti della separazione astratta e forzata tra competenze e conoscenze è, ad esempio, Giulio Ferroni:
“Ma ben diversamente da quanto sbandierano i pedagoghi delle competenze, si può pensare che ogni autentica competenza, in qualsiasi ambito, possa scaturire solo da un continuo confronto con la resistenza della realtà, da una investigazione del suo corpo concreto, in una maturazione di pensiero che sappia svolgersi in costruzione pratica, in un adattamento di sé, della propria mente e del proprio corpo, alle richieste e alle necessità imposte dai contenuti su cui si mira ad agire. Insistere sulle competenze sganciate dai contenuti comporta una sorta di evaporazione della sostanza concreta del sapere, della sua materialità e corporeità”.
Limitiamoci dunque alla questione del rapporto tra le competenze – considerate nel modo più neutrale e generico possibile, come un “saper fare” che arriva al termine di una serie di processi – e la dimensione cognitiva. Può aiutarci la definizione che l’onorevole Maurizio Lupi, presidente dell’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, ha dato delle “competenze non cognitive”, nel discorso in cui motiva la proposta della loro adozione adozione nell’ambito della legislazione scolastica del nostro Paese:
“Con character skills, soft skills o non cognitive skills si intendono tutti quei modi di definire un apprendimento in ambito scolastico e lavorativo che non sia limitato solo al coinvolge le capacità cognitive (ricordare, parlare, comprendere, stabilire nessi, dedurre, valutare) ma che implichi anche lo sviluppo di tutte quelle predisposizioni della personalità (l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la sicurezza personale, la capacità di prendere iniziative, di pensare per problemi, la capacità di auto-regolarsi, l’affidabilità, l’adattabilità, ecc.) che sono sempre più rilevanti nella società moderna”.
Quando si parla di “adattabilità” e “affidabilità” sembra davvero che ci si muova al confine tra il terreno della crescita e della formazione della persona e quello dell’azienda e della produttività lavorativa; e quando Lupi parla delle competenze del “pensare per problemi” o del “prendere iniziative”, ci si può legittimamente chiedere su quale base si possano risolvere problemi o prendere iniziative se non si ha la conoscenza – cognitiva, immaginiamo – di tali problemi e del contenuto di tali iniziative. Un’operatività non sostanziata da processi di pensiero, insomma, sembra una contraddizione in termini, a meno che non si esca dall’ambito dell’educazione non si entri in quello dell’addestramento; ma questo passaggio, come è ovvio, non riguarda e non può riguardare la scuola.
Forse, quando parla di “competenze non cognitive”, qualcuno intende fare riferimento, oltre a quelle operative, anche alle dimensioni affettive, relazionali ed etiche dell’essere umano. Ma – tenendo conto delle riflessioni svolte nella prima parte del presente articolo – pensiamo davvero che sia possibile separare tali dimensioni da quella cognitiva? Come si proponeva sopra, il termine “competenza” potrebbe essere utilizzato per sintetizzare tutta una serie di processi cognitivi, di processi di pensiero, in cui intervengono sistemi complessi dell’essere umano come la memoria, le emozioni e la storia personale. Per fare un esempio attinto dalla pratica psicoanalitica, affermare che una persona ha una buona capacità di capire, pensare ed elaborare le proprie emozioni, equivale a dire che questi ha una certa competenza nel leggere e integrare i propri stati emotivi. Difficilmente si potrebbe dire la stessa cosa di una persona che non è in grado neanche di dare un nome alle proprie emozioni o addirittura di percepirle, di dire o pensare ciò che prova. Non si può avere una competenza sulle emozioni se prima non le si conosce, o se non si eliminano le barriere che non permettono questo processo di conoscenza. Come ci ha insegnato Bion (1970-1973), le emozioni esistono sempre, anche quando si manifestino soltanto tramite equivalenti fisiologici (elementi Beta), senza raggiungere una adeguata capacità di essere pensate e dichiarate; oppure possono essere presenti in seno a una funzione Alfa acquisita, matura, che ci permetta di pensarle, esprimerle ed elaborarle.
Ecco, le “competenze non cognitive” producono in quest’ottica un grande paradosso. Come posso pensare alle competenze senza pensare? Come posso sapere di essere competente se non so cosa ho appreso, come posso sentirmi competente senza aver attraversato tutta quella serie di processi cognitivi che hanno fatto della mia esperienza reale, integrata con le emozioni, un’esperienza di crescita, di insegnamento, di apprendimento e di relazioni? Questi processi interni si proiettano poi in attività esterne, che richiedono regole e strumenti pratici; i processi cognitivi e di apprendimento possano concretizzarsi in quelle che, solo in futuro, si chiameranno competenze; ed ecco che il sistema pedagogico interviene come facilitatore dell’integrazione e dell’applicazione pratica di tutti questi sistemi interni.
Venendo alla concreta attività scolastica, è utile osservare come negli studenti e nell’apprendimento dimensione cognitiva e non cognitiva interagiscano di continuo. D’altra parte, in qualsiasi attività in cui l’essere umano è impegnato nel suo processo di vita, è auspicabile che vi sia sempre un funzionamento cognitivo-emozionale, il che significa che anche nell’insegnamento e nell’apprendimento (che riguarda sia l’insegnante che lo studente) è necessaria un’integrazione tra i processi di pensiero e il sistema legato agli affetti e alle emozioni, per i motivi accennati in sintesi nelle pagine precedenti. Se i sistemi cognitivi permettono di utilizzare tutti gli strumenti di cui il sistema intellettivo dispone per apprendere e far apprendere agli altri, il sistema legato alle emozioni permette di rendere questo processo integrato ad un senso di identità stabile, quella dell’insegnante e quella in fase di sviluppo dello studente. Anche se è idea ormai condivisa che l’identità del soggetto è in continuo divenire ed evoluzione, è anche vero che esiste una stabilità di base di un’identità che abbia raggiunto un sufficiente di livello di integrazione proprio di questi due importanti sistemi.
Ma c’è anche dell’altro. La scoperta dei neuroni specchio (Rizzolatti; Sinigaglia 2006) nel nostro sistema nervoso centrale ha permesso di chiarire in parte la modalità con cui la nostra mente riesce a entrare in risonanza con l’altro; questa caratteristica specchio è lo strumento con cui la persona può essere potenzialmente in grado di attivare un processo di mentalizzazione, capire ciò che accade nella propria mente ma anche sentire ciò che accade nella mente dell’altro, attraverso la risonanza emotiva rispetto a ciò che prova l’altro. Si tratta della una capacità di parti del cervello umano di attivarsi alla percezione delle emozioni altrui, espresse ad esempio con moti del volto o gesti (quelli che in gran parte si perdono, ad esempio, nelle attività di “didattica a distanza”), e codificare istantaneamente in termini viscero-motori tali percezioni dando vita a quell’importantissima capacità dell’essere umano denominata “partecipazione empatica”. In che modo questo discorso è importante nel processo di apprendimento e di insegnamento? Se insegnante e studente nella loro relazione entrano in una situazione di risonanza emotiva reciproca, che è incanalata nel contenuto culturale che si sta trasmettendo-ricevendo (anche in entrambe le direzioni), tale risonanza determinerà una migliore capacità di insegnamento e di apprendimento; se si tratta di emozioni positivamente incanalate, esse determineranno una maggiore possibilità di ritenere l’informazione da parte dello studente e di provare il piacere dell’insegnamento da parte del docente, piacere che rappresenterà l’espressione di un’identità professionale integra e sana.
Bisogna qui ricordare un’importante verità: il rapporto tra insegnanti e studenti non può che essere un rapporto anche affettivo (che non significa semplicisticamente “affettuoso”, ma che mobilita sentimenti di ogni tipo, incluse la rabbia o la frustrazione) secondo le modalità che gli sono proprie, diverse da quelle di cui si nutre il legame familiare; questa specificità della scuola, che rappresenta per gli studenti la prima importante esperienza sociale extra-familiare, le assegna una enorme potenzialità evolutiva, sia nell’incontro con i coetanei, sia in quello con adulti diversi dai genitori: è proprio spostando le proiezioni e gli affetti per l’insegnante sui contenuti culturali che questi gli propone, che lo studente riesce contemporaneamente a innamorarsi di tali contenuti – ad attualizzarli e a farli propri, a trovarvi risposte alle proprie domande di senso – e a elaborare le proprie dinamiche interiori, cioè a crescere sia dal punto di vista umano sia da quello culturale, che rappresentano in realtà due facce della stessa medaglia.
Oggi invece sta prendendo corpo una visione scissa di ciò che accade realmente a scuola e nei processi cognitivo-emozionali che vi si attivano, la visione per cui bisognerebbe superare “la cultura del sapere e della conoscenza” ed accedere, appunto, a una scuola delle “competenze non cognitive”, non legate cioè all’acquisizione e all’elaborazione di conoscenze. Se si tiene conto di tutto ciò che abbiamo scritto sopra a proposito del fortissimo legame che esiste sempre tra dimensione cognitiva e dimensione emotiva, questa idea non può essere accettata: se è vero che la condivisione dei contenuti culturali è il tramite su cui si costruisce la relazione tra studenti e insegnanti all’interno della classe e se, viceversa, l’interesse per i contenuti culturali è per le persone in crescita la modalità più adeguata e sana di mettere alla prova le proprie capacità intellettive e di tradurre e rielaborare le proprie dinamiche affettive, è chiaro che chi pensa di sottrarre alla scuola la dimensione della conoscenza e della scoperta culturale rischia di far venir meno anche la specificità della relazione educativa e di trasformare la scuola in un luogo vuoto, privo sia di conoscenze, sia di possibilità di rielaborazione del proprio vissuto e di relazioni affettive significative.
Ecco, questa è solo una delle possibili sintesi con cui tentare di spiegare l’importanza, ‘psicofisiologicamente’ naturale, dell’integrazione tra processi cognitivi, di pensiero, e processi non cognitivi, legati agli affetti e alle emozioni. Quello che vorremo trasmettere con quest’articolo non è la disamina completa di concetti della psicologia e della neurobiologia che richiederebbero ben altro spazio, ma l’applicabilità di alcuni di questi importanti concetti al sistema scuola e al processo di insegnamento e apprendimento consapevole. Essendo concetti che nascono dallo studio di dinamiche profonde dell’essere umano, possono essere applicati agli ambiti – come quello scolastico – in cui entrino in gioco tutte le più importanti dimensioni costitutive della persona. Nell’esperienza clinica capita spesso di dover aiutare i pazienti a superare paralisi psichiche nell’eseguire verifiche scolastiche o esami universitari. Molte psicoterapie nascono proprio a partire da questo problema. È soprattutto grazie ai pazienti se l’attenzione di uno dei due autori di questa riflessione si è spostata ai processi psicologici legati alla relazione tra insegnante e studente, e all’interrogarsi su come questi intervengano nel determinare un risultato positivo o negativo con le possibili ripercussioni sull’identità dell’insegnante e dello studente. In tal senso, l’incontro della psicoanalisi con il mondo dell’insegnamento può rivelarsi particolarmente fruttuoso, ricco di stimoli, di possibilità di comprensione profonda di ciò che avviene nelle aule scolastiche, di preziose indicazioni a supporto degli interventi educativi e didattici per il futuro dei nostri ragazzi.
***
Note
- “Questa visione dell’educazione attiva è in profondo contrasto con quella praticata attraverso le ‘competenze’. L’educazione attiva, per essere veramente tale, deve porsi l’obiettivo di fornire ai bambini e ai ragazzi gli strumenti per incidere sulla realtà, per modificarla attraverso una comprensione individuale e un’azione comune. L’approccio per ‘competenze’, al contrario, si basa su una adesione alla realtà esistente come se questa possedesse una realtà propria (il reale non è razionale, sosteneva Dewey). Non si propone di sottoporla a una lettura critica, tanto meno di cambiarla. Il suo scopo è – al contrario – quello di fornire a ciascuno gli strumenti per adattarvisi. La sua azione è modellata sugli individui singoli, privi di legami sociali, che devono essere dotati di propri ‘portafogli’ di competenze e formati per massimizzare il vantaggio personale che può derivare da un loro uso accorto sul ‘mercato’. In questo modo le finalità individuali e sociali vengono separate, viene ricostituita un’opposizione artificiale tra dimensione personale e dimensione comunitaria. Non stupisce che questa visione pretenda di fare tabula rasa di una ricca tradizione pedagogica costruita intorno al nesso tra individuo e società, tra educazione e democrazia. Stupisce, semmai, che un nuovo filone pedagogico si presti a legittimare questa mutazione. Nella costruzione delle ‘competenze’, i pedagogisti arrivano a giochi già fatti. Il loro ruolo prevalente è diventato quello di fornire – a posteriori – un quadro teorico di riferimento a un concetto che nasce, come abbiamo visto, su un terreno diverso rispetto a quello educativo. Per renderlo credibile, si cerca di costruire intorno ad esso una genealogia, alla ricerca di radici antiche e padri nobili, senza preoccuparsi troppo dell’eterogeneità delle correnti di pensiero chiamate in causa. Lo scopo è piuttosto quello di fornire una narrazione che ‘concili l’inconciliabile’, di legittimare il fatto che l’orientamento delle politiche educative sia spostato dal complesso delle dinamiche sociali a una loro declinazione specifica ed esclusiva: l’economia e l’impresa” (Mauro Boarelli, Contro l’ideologia del merito, Bari-Roma, Laterza, 2019, pp.25-26).
- Mauro Boarelli, cit., pp.26-27
- Giulio Ferroni, La scuola impossibile, Roma, Salerno editrice, 2015, p.58
- https://www.mauriziolupi.it/2021/11/29/legge-sulle-soft-skills-in-discussione-alla-camera/
- Si vedano a tale proposito alcune definizioni presenti sul sito dell’INVALSI (https://www.invalsiopen.it/cosa-sono-servono-soft-skill/ ): “Le soft skill sono competenze basilari, o abilità fondamentali, che possiamo definire come competenze che aiutano gli individui ad adattarsi e ad assumere atteggiamenti positivi in modo da riuscire ad affrontare efficacemente le sfide poste dalla vita professionale e quotidiana. Non c’è però una definizione univoca accettata universalmente. A seconda del quadro teorico di riferimento, i ricercatori le chiamano social skill, competenze fondamentali, competenze trasversali, competenze relazionali e sociali, meta-competenze o life skill. Quest’ultima espressione, competenze per la vita, è quella adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stilato un suo decalogo al riguardo. L’OCSE e l’Unione Europea parlano invece di competenze chiave – rispettivamente di Competenze chiave per una positiva vita attiva e per il buon funzionamento della società e Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Questa pluralità di denominazioni non cambia però la loro sostanza. E forse la definizione più semplice possiamo farla per differenza: le soft skill sono tutte le abilità che non rientrano nelle hard skill. Le hard skill sono infatti le competenze tecnico-specialistiche, che dipendono dal bagaglio formativo personale e dalle nostre esperienze pregresse.Hard skill e soft skill sono quindi complementari, le prime definiscono quanto sappiamo, le seconde invece chi siamo. Quali sono quindi le soft skill?Le soft skill includono abilità sociali, comunicative e linguistiche, assertività, comportamenti e atteggiamenti che si manifestano a livello sia personale sia relazionale.Non esistendo una definizione univoca, non esiste nemmeno un elenco esaustivo di queste competenze fondamentali, ma per farci un’idea possiamo leggere il decalogo delle life skill stilato dall’OMS, costituito da 10 competenze racchiuse in 3 macroaree: Competenze emotive: Consapevolezza di sé, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress; Competenze relazionali: Empatia, Comunicazione efficace, Relazioni efficaci; Competenze cognitive: Risolvere i problemi, Prendere decisioni, Pensiero critico, Pensiero creativo [qui, se non altro, a differenza di quanto detto nell’intervento dell’on.Lupi, il “risolvere problemi”, il “prendere decisioni” ecc. vengono ascritti alle “competenze cognitive]”.
- Freud (1925).
- Si veda in proposito l’intervento di Valentina Aprea, accesa sostenitrice delle “competenze non cognitive” e critica nei confronti della “cultura del sapere e della conoscenza”, nell’incontro sulle competenze non cognitive del già citato intergruppo parlamentare per la sussidiarietà con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, dell’8 giugno 2021.https://www.youtube.com/watch?v=cRu-2mSDcFA
Riferimenti bibliografici:
Bion, W.R. (1970) Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Armando Editore, Roma.
Bion, W.R. (1973) Gli Elementi della psicoanalisi. [Elements of Psycho-Analysis. London, Heinemann, (1963)].
Boarelli, Mauro, Contro l’ideologia del merito, Bari-Roma, Laterza, 2019.
Freud, S. (1925), Inibizione, sintomo e angoscia, in Opere, vol.10, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
Ferroni, Giulio, La scuola impossibile, Roma, Salerno editrice, 2015.
Krystal H. (1968), Integration and Self Healing: Affects, Trauma and Alexithymia, Hillsdale, Analytic Press, 1988 New York.
Iacoboni Marco, (2008), I neuroni a specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Torino, Bollati Boringhieri.
Liotti, G. (1993), La discontinuità della coscienza. Etiologia, diagnosi e psicoterapia dei disturbi dissociativi, II ed., Franco Angeli, Milano.
Pally R.(2003), Il rapporto mente cervello, Giovanni Fioriti Editore, Roma.
Rizzolatti G., Sinigaglia C., (2006), So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore.
Siegel D. J. (1999), The Developing Mind , Guilford Press and Mark Paterson , trad it. Luisa Madeddu. Raffaello Cortina Editore, Milano 2001.

Scritto molto significativo.
Sulle cosiddette competenze non cognitive, a non pensar male si radica la loro condizione di possibilità nell’estrema aridità oggi imperante nella scuola (dovuta alla pervasiva oggettività); ecco che la parte emotiva va riscoperta. Solo che farlo senza contenuti è essa stessa una risposta altrettanto oggettivata, che cura la malattia con lo stesso virus che l’ha generata.
A pensar male, invece, viene in mente il cane di Pavlov. In fondo l’azione senza pensiero è la più immediata (e dunque la più pronta, efficiente e soprattutto prevedibile). Evitare l’orpello del pensiero, per chi comanda, significa meno intralci, più linearità e perciò meno perdite di tempo. Vuoi mai che uno alzi la mano per contestare in un Collegio docenti col rischio che poi altri lo seguano, svelando l’incapacità di giustificare sotto il profilo umano certe scelte fondate sull’ideologia della dirigenza (il fantomatico staff)? E quanto più produttivo è il criceto che lavora in fabbrica, una volta che si è separato chi esegue da chi comanda?
Se la prima ipotesi si annulla da sé, non resta che la seconda.
"Mi piace""Mi piace"
insegno italiano ai migranti come L2 e scopro,in una situazione particolare, ogni giorno come il rapporto umano, la relazione sono fondamentali per favorire il sapere e la conoscenza, strumenti indispensabili per l’inclusione nell’uguaglianza.
"Mi piace""Mi piace"