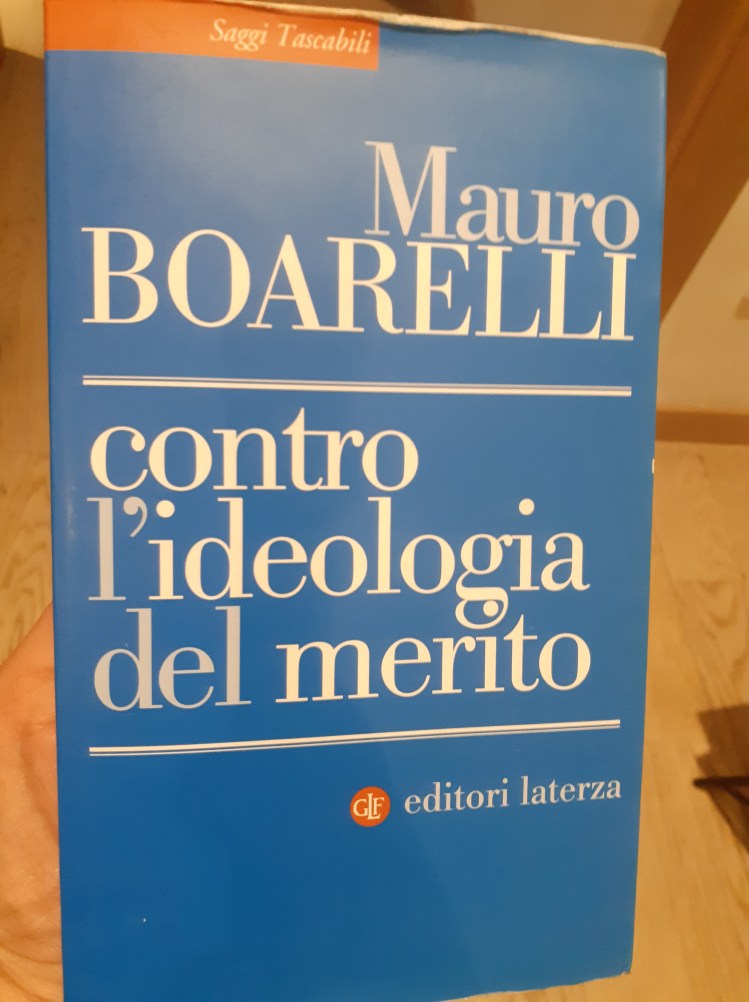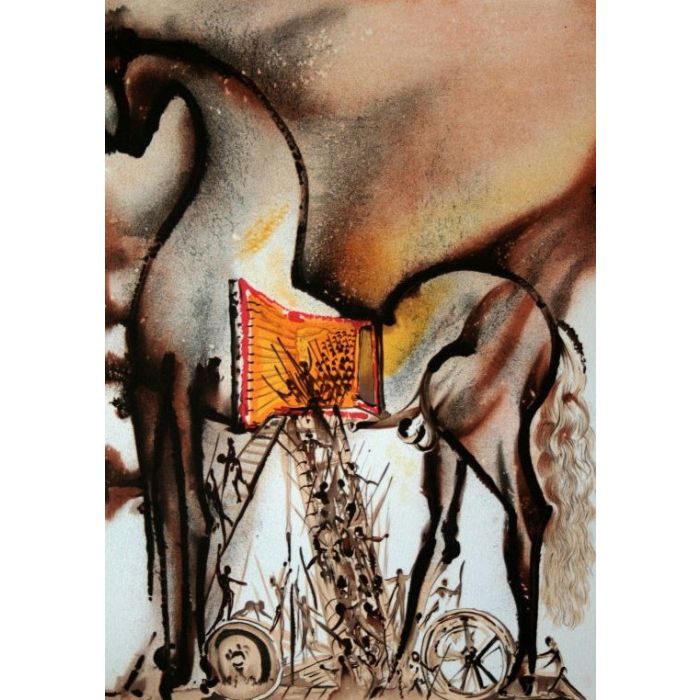di Davide Viero
Riportiamo qui l’intervento di Davide Viero al convegno La scuola italiana nell’epoca della sua aziendalizzazione, organizzato da CESP Cagliari e Oltrescuola che si è svolto a Cagliari venerdì 27 febbraio 2026.
Ringrazio sinceramente gli amici dei Cobas di Cagliari e Oltrelascuola per l’invito a parlare in questo convegno.
Nel mio intervento cercherò di portare l’attenzione su di un particolare – ovvero il concetto di inclusione – che però è rivelativo di una dimensione molto più ampia. Porre l’attenzione su di un concetto specifico sarà dunque la via per fare luce sul contesto generale, perché universale e particolare sono intimamente correlati e si manifestano l’uno nell’altro.
Ciò che dirò si pone in continuità con l’intervento di Andrea De Giorgi che abbiamo appena ascoltato, dal momento che precondizione al concetto di inclusione è la società aziendalizzata ed economicizzata, dove il soggetto è ridotto a individuo inteso come “capitale umano”. Un concetto, questo di capitale umano, che rivela una informità, simile al concetto aristotelico di potenza, ovvero come riserva di forza che può assumere infinite forme nel momento in cui si compie. Ogni estrinsecazione di queste forme certifica il suo sfruttamento, non la sua emancipazione, proprio perché questo capitale si situa in una dimensione apolitica ed apparentemente neutra che sembra renderlo buono per tutte le stagioni e a disposizione di chiunque; e proprio per questo di facile esproprio.
Da questa premessa svilupperò il mio intervento, che dividerò idealmente in tre parti. Una prima di impronta storico/sociologica, una seconda centrata sul concetto stesso di inclusione ed infine una terza di prospettiva, volta a riaprire lo scenario per trovare altri concetti, altre parole per un cambiamento “in meglio”.
In merito all’inquadramento storico/sociologico, possiamo inscrivere il concetto di inclusione perfettamente all’interno dei cardini epocali, che sono gli stessi che hanno generato l’aziendalizzazione della scuola. Il concetto di inclusione compare infatti contemporaneamente alla concezione neoliberale come compensazione alla competizione, che ne è il tratto caratteristico; stratagemma utile per estrarre valore da ogni cosa ed accentrarlo in poche mani. A conferma del fatto che si accordi perfettamente a questo tempo – che di capitalismo è intriso – ce lo dice la sua piana diffusione e la quasi sacralità che avvolge il concetto. Lo usano senza distinzioni tutte le forze politiche, i papi, il Presidente della Repubblica etc. Sembrano non esserci ombre per questo concetto, che risulta ecumenico. Chi infatti è contro l’inclusione?
In questo mio intervento premetto l’avvertenza che lavorerò sull’inclusione a livello concettuale, che è quello che sottende le decisioni politiche da qualche decennio a questa parte, perché poi so benissimo che nella realtà l’inclusione si presenta in maniera spuria e bisogna evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca.
Per quanto dirò è chiaro il mio debito verso Foucault e il suo “Ordine del discorso”. Secondo l’Autore francese ogni concetto ha un ordine del discorso alle spalle, un qualcosa che lo sorregge, lo determina, lo significa e lo fa esistere. Faccio un esempio banale; se io parlo di Inferno oggi, cosa posso suscitare se non indifferenza? Provate a pensare 300 anni fa cosa provocava questa parola. Perché essa non suscita più tali reazioni? Perché, secondo Foucault, è cambiato l’ordine del discorso. Nel caso dell’inclusione, qual è l’ordine del discorso? Dobbiamo presupporre che ogni nuova parola compaia perché migliore della precedente? O forse lo è perché risponde meglio ai criteri che nel frattempo sono cambiati?
Per dimostrare questo passaggio di “ordine del discorso”, farò tre esempi che lo precedono, tutti presi nella seconda metà del ‘900; ovvero segregazione/differenziazione – liberazione/emancipazione – integrazione ed infine abbiamo poi la nostra inclusione.
Ecco, vorrei far vedere che l’esclusione/differenziazione non nascono dal voler stigmatizzare il soggetto, ma dalle particolari condizioni materiali unite ad una particolare concezione di futuro. Nel Dopoguerra, infatti, era tutto da costruire e la scuola doveva licenziare studenti molto preparati per ciò. Questo futuro ancora aperto, da costruire, era il criterio di selezione. Successiva a questa fase c’è sta la liberazione/emancipazione, soprattutto in psichiatria. Concezione sorta a seguito della scoperta dell’individuo grazie al contributo dell’esistenzialismo. L’excursus storico procede poi con il concetto di integrazione, che compare dopo che la spinta propulsiva di un futuro da costruire aveva cominciato a rallentare e facendo sorgere l’esigenza di distribuire il molto così costruito. Le istanze della società, del futuro da costruire andavano accordate a quelle del singolo, di ogni singolo, che doveva avere un ruolo all’interno della realtà.
Cos’è successo poi? Da una trentina d’anni il mondo ha cominciato ad assumere una forma sempre più rigida, rispondente ad un’unica grande narrazione, come la chiama Lyotard; il futuro ha perso spinta e mordente a favore del presente (dialettica parlamentare, nuova egemonia etc.). Un presente già compiuto e solidificato che annulla un futuro diverso. Un presente non oltrepassabile, inemendabile. Un dato di fatto da assumere in forma assiomatica. Se quindi il presente è già dato e il futuro si risolve nella reiterazione del presente, questo diventa il centro di ogni azione ed il migliore dei mondi possibili cosicché l’unica opzione è essere inseriti in esso, non il costruire un futuro diverso. In-claudere, ovvero chiudere il soggetto nel presente tramite l’adattamento ad esso. Ecco l’inclusione. Essa è infatti l’adattamento al mondo così com’è. Anche la scuola stessa ha cambiato funzione: se essa era sorta per rispondere ad un’idea di futuro da scrivere e costruire, ora ha come obiettivo quello di includere in questo presente (da leggere in tal modo il PCTO, la pedagogia delle competenze etc.). Non serve più che essa insegni le discipline, ma deve trasformarsi in un’agenzia di socializzazione per come la società si è conformata, ovvero quella dello sfruttamento del capitale umano a fini economicisti. Ecco la cosiddetta “cattedra inclusiva” proposta da Ianes, Chiocca e altri. Una proposta che risponde esattamente a questi canoni estrattivisti, con i docenti trasformati in meri attori di socializzazione verso la status quo. Chi viene incluso, infatti, non sovverte le regole del gioco, non ha la possibilità di cambiare il corso delle cose; perché l’inclusione è un adattare quel tanto che basta quel che si fa già così che il soggetto, con le sue caratteristiche, vi possa prendere parte. Non si mettono certamente in discussione i principi sui quali tale contesto è fondato. Il concetto di inclusione porta così il trionfo dello status quo. Perché questo contesto nel quale si include è inemendabile e soprattutto è depoliticizzato. Il soggetto che viene incluso non può trasformarlo o metterlo in discussione perché esso, nei suoi assunti, rappresenta un assioma. Paradossalmente l’inclusione, che sembrerebbe mettere al centro il soggetto, in realtà mette al centro il mondo dato.
Nei confronti del singolo l’inclusione mostra indifferenza e deresponsabilizzazione, perché tutto si esaurisce nell’atto di includere, incurante di tutto ciò che avviene poi. Sembra dire l’inclusione: “Non m’importa chi sei, dei tuoi aspetti latenti che porti e che chiamano al compimento. L’importante è che tu sia dentro”; centrale è solo il diritto ad essere incluso. Una volta dentro poi sarà tutto demandato alla libera iniziativa degli attori in campo ed al contesto – come se questo fosse neutro – che decideranno in base a sensibilità ed interessi particolari. Si capisce bene che in questo caso sparisce ogni dimensione pubblica/collettiva – altamente emancipante perché chiama al confronto ampio – a favore di quella individuale. Verso il soggetto incluso prevale la tolleranza che maschera l’indifferenza verso la materialità del soggetto. L’inclusione non ha nulla a che vedere con una relazione umana forte e significativa volta a farsi carico dell’incompiuto che ogni soggetto porta con sé.
Com’è potuto accadere che succedesse tutto ciò senza che ne avvertissimo i rischi? L’espediente è stato quello di socializzare la disabilità così come ogni altro aspetto della vita. E questa socializzazione[1] è stata il grimaldello usato dalla razionalità neoliberista per chiudere l’orizzonte ed aprire le porte all’individualismo e all’interesse privato nascondendoli sotto un manto di pseudo -umanità. Questa socializzazione è da intendersi come restituzione ad una società disarticolata di ciò che prima aveva una direzione/tensione della quale anche le istituzioni si facevano latrici. Per quanto riguarda la disabilità, un ruolo importante l’ha rivestito il Capability approach, elaborato a partire da A. Sen, premio Nobel dell’economia. Secondo questo approccio la disabilità non è una caratteristica del soggetto, bensì è dovuta alla società. Al centro di questa concezione si trova il desiderio/bisogno del singolo. Se è soddisfatto, nessuno sarà disabile indipendentemente dalle altre condizioni. Si capisce bene che in un mondo ideale ciò potrebbe anche andare bene, ma nella realtà sappiamo che i desideri possono essere indotti e pure che si può desiderare qualsiasi cosa. Fondare tutto sul rapporto tra desiderio e soddisfazione dello stesso attraverso la società, è molto limitante. Se ci si ferma al desiderio, verso il soggetto non vi è nessuna considerazione. Facciamo un esempio: se mi manca un braccio io non sarò disabile se la società mi rende inutile l’uso dell’arto per soddisfare i miei desideri. Ma questo cosa comporta? Che nessuno si sognerà di emancipare questo soggetto, di fargli desiderare altre cose, di realizzare l’incompiuto che ognuno porta in sé e che va oltre i meri desideri, perché lo si rende succube di chi risponde al posto suo; un eccessivo peso alla dimensione esterna/ambientale comporta la conferma e l’indifferenza verso quella individuale perché essa non è considerata. Governare i desideri -che dipendono in gran parte dal contesto, perché non posso desiderare una cosa di cui non so l’esistenza – per chiudere il soggetto in una gabbia trasparente, facendolo sentire soddisfatto di quel che desidera senza la possibilità di trasformarsi e trasformare il mondo; un consumatore docile e mansueto, che dipende dalle dinamiche sociali e non sarà emancipato perché, rispondendo solo ai bisogni che di volta in volta emergono, sarà confermato nella sua minore età (per citare Kant). Socializzare la disabilità significa dunque eliminare la materialità della condizione umana e aver la possibilità così di ridurre la spesa sociale in termini di cura e riabilitazione, slegando il soggetto dalle istituzioni e legandolo al territorio, in quanto è proprio questo a determinare desideri e soddisfacimento degli stessi.
E siamo giunti alla terza parte del mio intervento. Abbiamo visto che nell’Occidente predomina lo status quo: sia nel versante soggettivo che nel mondo; il quale ha preso una forma assiomatica e compiuta in cui sembra che l’unica opzione possa essere l’inclusione, mentre dall’altra troviamo un soggetto che è confermato nella sua staticità rispondendo di volta in volta ai suoi limitati bisogni. Come fare a riaprire la prospettiva? E qui mi rifaccio a E. Bloch e al “Non” che caratterizza ogni presente. Un “Non” che chiama all’uscita da esso e che è oscuro perfino al soggetto che lo vive. Niente ricette preconfezionate quindi, ma solamente questo “Non” da far agire; un “Non” inteso come direzione e cambiamento in meglio.
Riaprire la prospettiva attraverso l’uso di nuove parole o riscoprendone altre, come può essere “integrazione”. Nel vocabolario integrazione significa completamento. E nel caso della disabilità tale completamento è dialettico, perché si completano tanto il soggetto quanto la società che accoglie e si adopera, in assenza punti di arrivo.
Un altro aspetto da riconsiderare per riaprire la prospettiva è quello medico che, al netto della medicalizzazione, ha in sé questo “Non” dal quale uscire. La medicina infatti ha lo scopo di emancipare e migliorare il soggetto facendo i conti con la sua materialità (ovvero la fisicità); agendo per lui e non nascondendo il problema nella socializzazione. Percorsi di cura e terapia sono fondamentali sulla via dell’emancipazione e del compimento. Oggi purtroppo assistiamo alla mera certificazione burocratica da parte delle ASL[2], certificazione che è un aspetto della socializzazione in quanto è la presentazione alla società di una persona nel suo status quo, senza che vi sia ulteriore prosecuzione, dato che cura e riabilitazione sono in questo presente pressoché inesistenti[3]. Noi oggi chiamiamo medicalizzazione questa certificazione indifferente che non cura. Sappiamo purtroppo che questa socializzazione della medicina è stata usata dal neoliberismo per tagliare i servizi per ridurre la spesa pubblica (ma questo è un altro capitolo).Chiudo col raccontarvi un fatto. Quest’autunno Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, ovvero quella pizzeria milanese dove lavorano tanti ragazzi con sindrome autistica, è stato audito in Decima commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale. In tale Commissione ha affermato che per i ragazzi affetto da autismo il contratto a tempo indeterminato è fondamentale per dare una stabilità alle persone. Ma io mi chiedo: perché chiedere il lavoro a tempo indeterminato per una categoria e non per tutti? L’inclusione presuppone che la società sia formata da parti frammentate in competizione tra loro e dove tutti aspirino ad entrare nella migliore, in un gioco competitivo in vincolo di risorse. Ma questo ci dice che l’inclusione, come concetto, è irrealizzabile (a meno che non si voglia creare quella società di consumatori individuata da L. Russo in Segmenti e bastoncini) perché esso si incarica di rendere accessibili i punti di arrivo e lo fa in modo astratto, senza considerazione alcuna per la materialità. Se sono senza braccia, non posso dire che la società non è inclusiva perché non mi permette di fare il cardiochirurgo. Dobbiamo trovare dunque altri concetti, non per garantire il risultato inteso come prodotto da acquistare, ma per far sì che ognuno possa aspirare al compimento di ciò che porta di manifesto e di latente; e per questo i diritti sociali sono una parte essenziale. Tutto ciò al di fuori della frammentazione, in un clima di unità. Più che inclusione, che rivela un accentramento, ci vuole il suo moto opposto ovvero la distribuzione.
Perché è inutile ricercare continuamente l’inclusione – che come abbiamo visto non potrà mai essere totale – mantenendo intatta la condizione che la genera, ovvero la competizione. No, la società per cui combattere non è quella dell’inclusione, ma quella – tra l’altro costituzionale – dell’uguaglianza.
Note
1 In Veneto tutta la parte riguardante la disabilità è passata in capo alll’INPS. Sembra quasi che la stessa disabilità sia solo questione di previdenza sociale e non di cura e riabilitazione.
2 Significativo cogliere il cambiamento di prospettiva attraverso la documentalità. L’ICF riduce l’essere umano ad una sommatoria statica di funzioni senza prospettiva che farà coincidere il soggetto con la sua disabilità; tale documento sostituisce l’ICD che invece diagnosticava sì una malattia, ma certificando la malattia apriva la via per prendersi cura della guarigione o del miglioramento.
3 A scuola la certificazione porta ad un abbassamento dei livelli attraverso dispensazione e semplificazione, quindi ad un impoverimento per lo studente. Si esclude che egli possa migliorare attraverso un percorso che porta più lavoro, fermandosi invece al dato di fatto certificato, pur trattandosi di età evolutiva. Senza contare che in una classe le certificazioni portano ad una istruzione personalizzata, quando compito della scuola sarebbe invece quello di far acquisire un nucleo condiviso di conoscenze considerate fondamentali dalla società attraverso il confronto con i compagni che eleva.