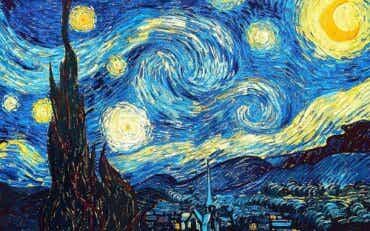Pubblichiamo qui l’importante documento con cui i genitori del Liceo Pilo Albertelli di Roma hanno spiegato le motivazioni della bocciatura, da parte del Consiglio d’Istituto, del PNRR che si voleva imporre loro. Si è trattato di un gesto simbolico di grande importanza, in un contesto di analoghe forzature imposte frettolosamente dall’alto, in una prospettiva di mutamento e stravolgimento della natura dell’istruzione pubblica del nostro Paese. In questo stravolgimento è molto difficile ravvisare motivazioni di ordine didattico, culturale, educativo, ed è quasi inevitabile ipotizzare l’esistenza di altre motivazioni.
NOTE DEI RAPPRESENTANTI GENITORI SUL PROGETTO “SCUOLA 4.0”
Il 4 maggio scorso il Consiglio d’Istituto della nostra scuola ha discusso due progetti per il Piano “Scuola 4.0, Labs e Classrooms” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
I due progetti, che portano la data del 24 e 25/02/2023, sono stati elaborati personalmente dal Dirigente Scolastico e sono stati portati a conoscenza dei consiglieri di istituto solo il 28/04/2023; non erano stati sottoposti al Collegio dei Docenti e neppure alla competente commissione nominata dallo stesso Collegio dei Docenti; su richiesta di uno studente, il Dirigente Scolastico ha spiegato di non aver coinvolto gli studenti in quanto la loro partecipazione non era prevista in questa fase.
Dopo un’approfondita discussione, i due progetti sono stati respinti con 7 voti contrari (4 docenti, 1 studente, 2 genitori), 2 favorevoli (dirigente scolastico e 1 genitore) e 4 astenuti (3 studenti, 1 personale ATA).
Riassumiamo qui le ragioni per cui abbiamo valutato che fosse necessario esprimere un voto contrario, nell’interesse formativo dei nostri figli/e e per difendere il ruolo che la Costituzione attribuisce alla scuola, dando così seguito agli intenti sulla base dei quali siamo stati eletti 1
I finanziamenti europei del PNRR non hanno l’obiettivo di prendersi carico delle necessità impellenti della scuola italiana e risolverne i problemi storici: l’abbandono elevato, le carenze edilizie, l’assenza di manutenzione e sicurezza, le classi sovraffollate, la precarietà permanente di docenti e personale ATA, la mancanza di spazi idonei per la didattica ordinaria, ecc. restano inevasi, anzi si aggravano poiché le risorse vengono destinate unicamente alla nuova tumultuosa emergenza “innovazionista”.
I due progetti per l’Albertelli2
- Next Generation Labs. Questo progetto prevede lo sviluppo delle “professioni digitali del futuro” che gli studenti del Liceo Albertelli dovrebbero acquisire: “esperti in Video Making, Produttori di Musica Digitale, Curation Manager (cura le nuove uscite nelle playlist, sic), Digital Curator, Social Media Manager, Social Media Editor, Digital Media Curator…”. Secondo il testo del progetto, le relative “competenze digitali specifiche” sono: “saper girare video con uno smartphone, saper realizzare filmati e pillole per i social con attenzione crescente ai contenuti per le Instagram stories, saper analizzare i dati e i trend di ascolto streaming dei brani musicali…”. Per queste nuove competenze si sarebbero spesi 124 mila euro, di cui oltre 12.000 per “progettazione, spese tecnico-operative e per gli obblighi di pubblicità”: crediamo che esse mostrino un’estrema povertà di contenuti e stridano con gli obiettivi di un liceo, cioè insegnare a tradurre dal greco, a comprendere la storia e la fisica, avere una capacità critica e un metodo di studio, non a usare Spotify e Instagram.
- Next Generation Classroom. Prevede l’acquisto di digital board, tablet e stampanti al fine di trasformare le aule scolastiche in “ambienti ibridi” di apprendimento: questo nuovo assetto dovrà determinare a cascata “innovazioni organizzative, didattiche, curricolari, metodologiche” che si adeguino alla “velocità delle comunicazioni” che caratterizza la nostra società. Molte parole vengono spese “sul benessere emotivo e lo stimolo relazionale, sullo sviluppo dell’empatia” degli studenti o sul “rendere protagonista l’alunno che si avvicina sempre di più alla scelta consapevole del proprio ruolo nella società”, senza che però vi sia alcuna spiegazione o evidenza su come i dispositivi digitali possano concorrere a questi obbiettivi. Neanche una parola invece è riservata alla profondità delle conoscenze che sono necessarie per comprendere – e non solo subire – una società sempre più complessa.
La nostra scuola è già dotata di 41 smart TV, 7 proiettori, 49 PC Notebook, 41 PC Desktop: pertanto ci sembra irrazionale ed antieconomico sobbarcarsi collettivamente un debito di circa 150.000 € (di cui 15.000 solo per spese di “progettazione, tecnico-operative e per gli obblighi di pubblicità”) per ulteriori attrezzature multimediali che hanno una vita media brevissima e che quindi acuiscono, anziché arginarla, la percezione di vivere in un mondo effimero.
Non abbiamo quindi di fronte un finanziamento per dotazioni tecnologiche, ma un progetto di stravolgimento della scuola, che si focalizza sull’“aspetto professionale” (v. Labs) e su quello “accattivante e ludico” (v. Classrooms). Tramite Labs si scardina e svilisce il lavoro sistematico con continue interruzioni e con una visione che inchioda le giovani generazioni al ruolo di “forza-lavoro” priva di qualsiasi autonomia. Tramite Classrooms si punta a disarticolare il gruppo-classe, dimenticando che la formazione è un processo a cui concorrono molteplici fattori: propedeuticità tra argomenti; ritmo tra studio, esercizio, ripasso, elaborazione autonoma (non solo la propria ma anche quella che si sviluppa nel confronto con i pari); riferimenti continui alle comuni esperienze pregresse. L’apprendimento è un fatto collettivo; se viene meno la classe, viene meno il lavoro per “andare avanti insieme” grazie alle, diversità.
Crediamo che il miglioramento della didattica passi per ben altre vie e che l’attenzione spasmodica alla digitalizzazione significhi da un lato la riduzione tout court dell’importanza delle discipline umanistiche, della storia e della formazione del pensiero, dall’altra impoverimento e banalizzazione dello studio delle scienze, che rischia di ridursi ad un insieme precetti. Qualunque professione, presente o futura, necessita della premessa di un’istruzione seria, che anzitutto assicuri le conoscenze essenziali, che insieme appassioni e abitui alla chiarezza intellettuale: la formazione professionale degli studenti viene solo dopo la formazione integrale di base e per essa ci sono fior di corsi post-secondari o post-universitari.
La proposta che abbiamo respinto serve a formare acritici operai del digitale, togliendo tempo e risorse dalle conoscenze fondamentali, e disinvestendo sulla necessità di dare la preparazione necessaria per affrontare gli studi che consentano di comprendere e costruire le tecnologie del futuro e la complessità del mondo.
I punti salienti del Piano Scuola 4.0
Il Dirigente Scolastico non ha avuto margini nell’elaborare il proprio progetto: infatti il PNRR Scuola (elaborato da una società di consulenza nel settore dell’economia e della gestione delle risorse) è “un programma di performance” con traguardi a cui le scuole sono “funzionalmente vincolate” e che devono essere strutturate secondo precise istruzioni 3.
Obiettivo dichiarato ripetutamente è di accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearlo alle priorità definite dall’OCSE. Questo organismo economico definisce cosa devono essere gli “ambienti di apprendimento innovativo”, nei quali non esiste più il gruppo classe e si deve andare oltre i contenuti. Si devono configurare nuove dimensioni di apprendimento ibrido con esperienza immersiva in realtà virtuali e la possibile fruizione a distanza di tutte le attività didattiche 4.
Quale pedagogia?
Tutte le affermazioni “pedagogiche” riportate nel Piano sono prive di argomentazioni e fonti; un documento così fondamentale non contiene bibliografia ma solo sei citazioni, di cui una del World Economic Forum e tre dell’OCSE (organismi economici senza competenze didattiche o pedagogiche). Uno dei due testi citati come riferimento pedagogico sostiene idee molto diverse da quelle sottese al Piano Scuola 4.0: “il contenuto è cruciale per ogni insegnare e imparare” e tutte le forme di “pedagogia innovativa” sono sperimentali, da perseguire con grandissima attenzione e senza improvvisazione 5: il contrario di quanto sta avvenendo in Italia da alcuni decenni con l’idea che innovare nell’istruzione significhi mettere da parte le conoscenze, per sostituirle con le “competenze”. In merito, va evidenziato l’abbassamento dei livelli di formazione avvenuta in Italia proprio in tale periodo, in seguito al processo di standardizzazione, di progressiva digitalizzazione e di applicazione del modello aziendalista nelle scuole.
Digitalizzazione: per cosa?
La digitalizzazione dell’apprendimento quali effetti può avere su bambini ed adolescenti, e quale finalità persegue?
Un documento del Senato, dopo un’indagine conoscitiva approfondita afferma:
“… Dal ciclo delle audizioni svolte e dalle documentazioni acquisite, non sono emerse evidenze scientifiche sull’efficacia del digitale applicato all’insegnamento. Anzi, tutte le ricerche scientifiche internazionali citate dimostrano, numeri alla mano, il contrario. Detta in sintesi: più la scuola e lo studio si digitalizzano, più calano sia le competenze degli studenti sia i loro redditi futuri.”
A questo si aggiungono i gravi danni fisici (“miopia, obesità, ipertensione, disturbi muscolo-scheletrici, diabete”) e psicologici
(“dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, aggressività, insonnia, insoddisfazione, diminuzione dell’empatia”) e “la progressiva perdita di facoltà mentali essenziali, le facoltà che per millenni hanno rappresentato quella che sommariamente chiamiamo intelligenza: la capacità di concentrazione, la memoria, lo spirito critico, l’adattabilità, la capacità dialettica…” 6
Persino la stessa OCSE a settembre 2015 ha pubblicato un corposo studio in cui si riconosce che “nonostante i considerevoli investimenti in computer, connessioni Internet e software per uso didattico, ci sono poche prove concrete che un maggiore uso del computer tra gli studenti porti a punteggi migliori in matematica e in lettura”; in particolare, dai dati PISA 2013 emerge che nei paesi in cui è meno comune per gli studenti utilizzare Internet a scuola per i compiti, le prestazioni in lettura sono migliorate più rapidamente rispetto ai paesi in cui tale uso è in media più comune, e che i livelli di utilizzo dei computer al di sopra dell’attuale media OCSE sono associati a risultati significativamente inferiori 7.
Nel Piano si fa ripetutamente riferimento alla Didattica a Distanza e alla Didattica Digitale Integrata come orizzonte applicativo delle tecnologie, nonostante l’esperienza disastrosa sperimentata negli scorsi anni.
Modificando gli apprendimenti si snatura la funzione costituzionale della scuola
L’innovazione tecnologica appare così un metodo che punta a incidere sugli insegnanti: il Piano si propone di insegnare loro ex novo come esercitare la propria professione attraverso la formazione obbligatoria, dal momento che il loro bagaglio professionale non risulterebbe più adatto ai nuovi ambienti di apprendimento. Li si vuole vincolare alla cosiddetta didattica per competenze, alla standardizzazione valutativa e creare un assetto gerarchico nel quale si introducono referenti di progetti, docenti orientatori e una “leadership pedagogica” automaticamente selezionata secondo criteri di affidabilità e di fedeltà incondizionata alla transizione digitale.
La progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs) comporta un ripensamento di tempi, funzioni personali, relazioni e risorse e si prefigge di connettere ancor più strettamente la scuola agli imperativi economici e alle esigenze dell’attuale mercato del lavoro (non di quello futuro, aleatorio e imprevedibile), consentendo agli attori imprenditoriali di gestire in primis aspetti centrali della vita scolastica attraverso ingenti finanziamenti pubblici per la fornitura di macchine, formazione e consulenza.
È conclamato lo slittamento definitivo da una “Scuola della Costituzione”, che ha il fine ultimo di fornire la conoscenza capace di favorire un pensiero critico, autonomo e democratico, ad una tecnocrazia educativa che mira ad addestrare, non tanto “al lavoro”, ma “alle condizioni in cui si esercita il lavoro”: sottopagato, privo di diritti, precario, svuotato di creatività. Non a caso nei documenti ministeriali degli ultimi anni gli studenti vengono sempre più spesso definiti “capitale umano”, cioè come una sommatoria di competenze singolarmente misurabili e certificate per l’accesso al lavoro.
Siamo di fronte ad un processo profondamente politico che impone “il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione”8 attraverso dispositivi legislativi d’urgenza che azzerano il dibattito parlamentare. Esso modifica i rapporti tra scuola, stato e privati, sottraendo la ripartizione di risorse pubbliche alla possibilità di accertamento e controllo da parte dei soggetti direttamente interessati, esternalizza le credenziali educative pubbliche con connessa tracciabilità individuale e consolida processi verticistici che riducono il confronto dialettico, comprimendo ulteriormente la partecipazione collegiale.
I finanziamenti per il PNRR
I finanziamenti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono in grandissima parte soldi già nostri (il bilancio UE è alimentato dai trasferimenti degli Stati membri) che ci vengono elargiti a prestito per introdurre riforme e realizzare progetti decisi a livello europeo da organismi economici (in primis l’OCSE). Circa i 2/3 dei 191 miliardi per
l’Italia dovranno essere restituiti con tanto di interessi: ogni euro speso, pertanto, graverà sulle spalle dei nostri figli e nipoti in termini di debito pubblico e di futuri tagli a beni e servizi pubblici.
Vi invitiamo a parlarne all’assemblea dei genitori, aperta a tutte le componenti della scuola, convocata per giovedì 18/05/2023 alle ore 17.
Roma, 14 maggio 2023
Francesco Paolo Caputo, Serena Iacovelli
(rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto eletti nella lista n.2)
Note:
2 https://piloalbertelli.it/wp-content/uploads/Progetto-PNRR-LABS.pdf e https://piloalbertelli.it/wp-content/uploads/Progetto-PNRR-CLASS.pdf
3 Istruzioni Operative, pag. 8. https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-
UFFICIALEE.0107624.21-12-2022.pdf
4 Piano Scuola 4.0 pagg. 13 e 15
5 Paniagua, A. e Istance, D. (2018), “Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies,
Educational Research and Innovation”, OECD Publishing, Paris.
6 Documento approvato dalla 7a Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) nella seduta del 9 giugno 2021
“Sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” – XVIII Legislatura – Disegni di
Legge e Relazioni – Documenti – doc. XVII, n. 2
7 OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en