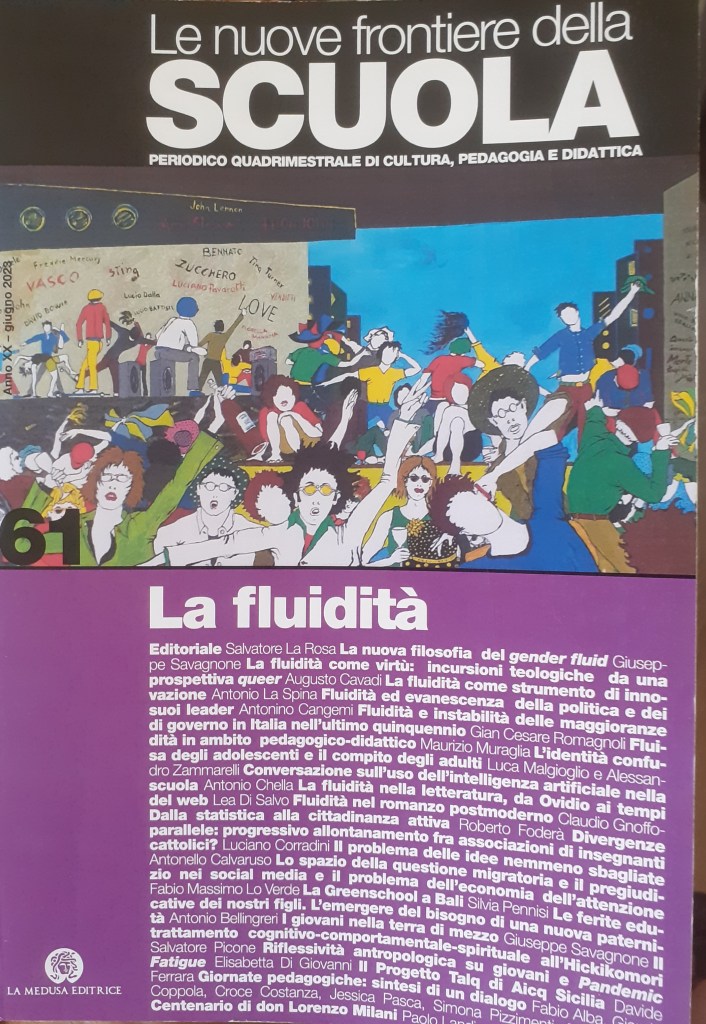Già venticinque anni fa Lucio Russo, con Segmenti e Bastoncini (Milano, Feltrinelli, 2016 [1ª ed.1998, 2ª ed. 2000]), aveva denunciato la vera natura delle “riforme” della scuola e ne aveva previsti gli esiti. Riportiamo qui qualche passo del libro.
«La grande maggioranza degli studenti della nuova scuola finirà semplicemente con l’assumere l’uno o l’altro degli infiniti ruoli di mediazione tra produzione e consumo nati per alimentare il mercato distribuendo in rivoli minimi parte della ricchezza che sgorga da poche sorgenti lontane e inaccessibili.
Le capacità e le competenze richieste per tali ruoli sono minime e diminuiscono di anno in anno. Le continue ondate di innovazione tecnologica, che immettono nel mercato prodotti sempre nuovi, spesso basati su tecnologie raffinate, richiedono in compenso masse di consumatori “evoluti”, attenti cioè alle novità, capaci di mutare continuamente le abitudini di consumo, abbastanza “colti” per recepire rapidamente i messaggi pubblicitari e leggere manuali di istruzioni, ansiosi di superare l’amico e il vicino nella rapidità di acquisto dei prodotti dell’ultima generazione, consumando in rapida successione i prodotti lanciati via via sul mercato.
In definitiva la nuova produzione, concentrata e automatizzata, richiede più conoscenze ai suoi clienti che ai suoi dipendenti. La nuova scuola deve quindi preparare soprattutto consumatori, oltre che contribuenti ed elettori. Queste figure, a differenza dei tecnici e dei dirigenti, possono ignorare i processi produttivi e, tanto più, fare a meno di qualunque tipo di cultura generale» (pp.18-19).
***
«Inoltre il processo di automazione del terziario inizia a coinvolgere anche la scuola. Le funzioni tradizionali degli insegnanti tendono a essere svuotate da tecnologie didattiche centralizzate e impersonali, grazie a lezioni televisive, videocassette, “ipertesti interattivi” e altri prodotti “multimediali”. Le attuali tecnologie, permettendo sia una percezione più ricca e piacevole di “fatti”, sia una maggiore autorevolezza nell’impartire insegnamenti prescrittivi, sono in effetti insuperabili nella comunicazione unidirezionale e acritica caratteristica della nuova scuola per consumatori. L’uso massiccio di tali strumenti nella scuola fornisce d’altra parte anche un apprezzato contributo all’avviamento al consumo tecnologico.
Alla nuova scuola non occorrono esperti di fisica, letteratura, filosofia o storia dell’arte. Una volta completata la trasformazione, basteranno dei generici “operatori scolastici”, con una preparazione essenzialmente socio-pedagogica, che svolgano la funzione di intrattenitori e animatori, accogliendo gli studenti nelle strutture scolastiche, stimolandone la socializzazione e accompagnandoli e guidandoli nella fruizione dei media.
Naturalmente via via che procede la
trasformazione degli insegnanti nelle nuove figure il loro prestigio sociale diminuisce, di pari passo con i loro stipendi.
Quanto agli intellettuali ai quali affidare le scelte di indirizzo culturale e la formulazione dei programmi, non saranno più letterati, matematici o filosofi […] ma degli “specialisti di scuola” scelti preferibilmente tra sociologi, pedagogisti o, ancor meglio, esperti di media. Non avendo più nulla da comunicare, la scuola non può che essere progettata e indirizzata da chi è esperto delle forme della comunicazione» (pp.23-24).
***
«I principi generali della riforma della scuola secondaria italiana avviata dal ministro Berlinguer possono essere sintetizzati in poche parole. Si tratta del progetto, coerente e organico, di smantellare quanto resta della tradizionale scuola secondaria superiore sostituendola con una moderna “scuola per consumatori” […].
Uno dei punti chiave del progetto di Berlinguer prevede l’ingresso massiccio nella scuola delle “nuove tecnologie”. L’uso di ipertesti, la navigazione in Internet e altre tecniche “multimediali” dovrebbero assicurare un salto di qualità alla scuola. Maragliano, il presidente della commissione dei quaranta saggi, ha dichiarato:
“Il videogioco è la più grande rivoluzione epistemologica di questo secolo. Ti dà una scioltezza, una densità, una percezione delle situazioni e delle operazioni che puoi fare al loro interno che permette di esaltare dimensioni dell’intelligenza e dello stare al mondo finora sacrificate dalla cultura astratta”.
L’obiettivo di deconcettualizzare l’insegnamento, espellendo i concetti astratti dalla scuola, è evidentemente ben chiaro a Maragliano. In lui l’entusiasmo per le nuove tecnologie è quello tipico dell’acquirente passivo, felice della novità e potenza del nuovo giocattolo, gioioso di immergersi totalmente nella realtà virtuale del gioco, ma apparentemente disinteressato sia alla comprensione della tecnologia (ovviamente inaccessibile a un pedagogista) che agli scopi per i quali potrebbe essere usata (che esulano dalle competenze di uno specialista in tecnologie multimediali). Si desidererebbe che Maragliano fosse lasciato giocare in pace.
A proposito delle nuove tecnologie didattiche la commissione dei quaranta saggi ha sintetizzato le sue conclusioni scrivendo:
“Maggiore attenzione, nell’ambito della didattica, dovrebbe essere data alla utilizzazione di una pluralità di strumenti educativi, quali:
-[…]
– impiego delle macchine della conoscenza e dell’elaborazione di informazione e problemi. In particolare gli strumenti multimediali sono estremamente motivanti per bambini e ragazzi, perché non hanno affatto odore di scuola, danno loro il senso di disporre di risorse per il saper fare e consentono di non disperdere, ma valorizzare, in un quadro intellettuale più strutturato, forme di intelligenza intuitiva, empirica, immaginativa, assai diffuse tra i giovani”.
Gli estensori del documento, convinti che la scuola puzzi per natura, raccomandano i nuovi strumenti innanzitutto “perché non hanno odore di scuola”. L’argomento è evidentemente tautologico: se ai bambini sembra che i libri, e non i computer, odorino di scuola, ciò è evidentemente dovuto al fatto che a scuola si usano molti più libri che computer. Riempiendo la scuola di computer ed espellendone i libri, saranno i computer a emanare “odore di scuola”. In ogni caso non si può evitare che la scuola odori di scuola; si dovrebbe piuttosto cercare di migliorare la qualità dell’odore» (pp.88, 90-91).
***
«La distinzione tra i due significati della parola “informazione” è essenziale poiché traduce l’ovvia constatazione che le immagini possono essere veicoli essenziali di conoscenza ma non debbono affatto esserlo necessariamente. Tutti possiamo notare che il più delle volte non lo sono.
Inoltre anche quando il contenuto conoscitivo è elevato (un quadro, una radiografia, il progetto di una macchina…) esse restano prive di significato per chi non possiede adeguati strumenti concettuali. E non vi è alcun modo per trasmettere strumenti concettuali senza usare la comunicazione verbale […].
Un aspetto essenziale della sostituzione dei testi scritti con immagini è l’unidirezionalità della comunicazione che ne risulta. Chi legge sa in genere anche scrivere, ma chi guarda immagini non ne può produrre con la stessa facilità. Quella per immagini è quindi una comunicazione a senso unico, nella quale il ruolo passivo del ricevente non è invertibile. Un messaggio verbale, orale o scritto, essendo costituito da simboli linguistici elaborati dall’uomo costituisce esplicitamente una comunicazione tra uomini, che per sua natura può essere analizzata e discussa con lo stesso strumento linguistico usato dall’autore. Un’immagine viene invece percepita come un oggetto non modificabile della realtà esterna e quindi le impressioni e le associazioni d’idee provocate dall’autore della comunicazione restano per il ricevente quasi sempre inespresse e non analizzabili» (p.45).
***
Ancora dal libro di Lucio Russo, che nella seconda edizione risponde alle critiche ricevute da qualche proto-esponente di una pedemagogia sempre schierata dalla parte del potere:
«Le idee di Carlini* sono state citate e riprese, poco dopo, sullo stesso “manifesto”, da Roberto Maragliano, che ha iniziato il suo intervento scrivendo:
“Finirà che dovremo ringraziare Lucio Russo e il suo libello (Segmenti e bastoncini) per aver stanato un nucleo forte, ben annidato anche nella cultura progressista, di resistenza al nuovo: non solo le novità che si annunciano nella scuola, ma anche e soprattutto quelle che si sono già affermate nel tessuto culturale della società. Una resistenza disperata, la sua. Un grumo di idee di opposizione che, capovolgendo i termini di una formula abusata, sembra rimandare a “il pessimismo della volontà e l’ottimismo della ragione”. Come dire? Il mondo va a rotoli, resto io solo ad avere ragione, in forza, appunto della “ragione” di cui sono detentore. Ma che ragione è mai questa? Assai fragile […]”.
La convinzione di Maragliano che il “nuovo” non debba essere scelto né discusso, ma semplicemente accettato appena identificato come “nuovo”, appena cioè mostra di avere la forza di affermarsi, il suo impegno venatorio a “stanare” chi gli oppone resistenza e la sua opinione che la ragione non valga nulla, e debba essere ridicolizzata e messa tra virgolette, se, pur essendo ragione, non può contare sul sostegno di forze sufficienti, non sono certo originali. Si tratta di atteggiamenti molto diffusi, con interessanti precedenti storici. Ad esempio il nazismo, che certamente apportò molte “novità” nel tessuto culturale della società, fu difeso con gli stessi argomenti contro le ragioni, per molti anni indubbiamente “assai fragili”, di chi gli oppose resistenza» (pp.127-128)
_____________________________________________
*[Le idee di Carlini consistono in un delirio di questo tenore:
“Non per caso, da vero matematico vecchia maniera, Russo apprezza del computer solo ciò che è ‘computeristico’, ovvero i modelli di simulazione e la sua logica stringente, mentre disprezza tutto quanto gli appare sfumato, Fuzzy, o, peggio ancora, visivo […] Certo è una reazione di paura e di smarrimento che ha dei fondamenti: un’intera categoria intellettuale si sente oggi messa in discussione e avverte che sta perdendo peso, via via che i beduini installano antenne sulla loro tenda (rimanendo tuttavia profondamente nomadi e beduini) e che la cultura – sì cultura – si propaga attraverso T-shirt, le scritte sui muri e gli aborriti videogiochi. Il libro […] non è più l’unico luogo dove le idee importanti si formano e si propagano. Del resto lo è stato solo per una fase della storia […]. C’è un prima, orale e visivo, che simbolicamente comincia con gli affreschi delle grotte di Lascaux, in Dordogna, e c’è un dopo in cui ormai siamo entrati…”.
Al che Russo risponde, con sublime ironia:
«Quello di scavalcare i millenni della cultura scritta e della razionalità, gettando un ponte ideale, sotto il segno comune dell’orale e del visivo, tra le nostre scuole e il paleolitico, è certamente un obiettivo grandioso per una riforma della scuola […].
Nell’intervento di Carlini l’aspetto che molti insegnanti mi hanno confidato di aver trovato particolarmente illuminante è stato il suo associare, come segni dello stesso “nuovo” che avanza, i progetti di Berlinguer ai beduini teledipendenti. I beduini apprezzati come innovatori (pur in un’improbabile fedeltà alle proprie tradizioni culturali) trascorrono la sera a osservare la TV nella propria tenda, ma si guardano bene dall’assumere qualsiasi ruolo attivo nella tecnologia televisiva. Se, infatti, volessero progettare televisori, stazioni trasmittenti e programmi, avrebbero certamente bisogno di quella “logica stringente” che Carlini non apprezza e vorrebbe eliminare dall’orizzonte mentale degli studenti italiani, che, essendo destinati a essere sudditi passivi della tecnologia, dovranno limitarsi anch’essi a montare sulle proprie tende solo antenne riceventi» (pp.126-127)].